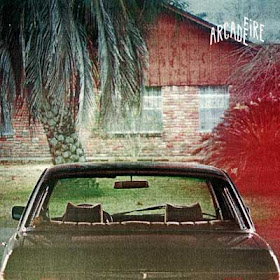Edgar Broughton fu, con ogni probabilità, uno dei protagonisti dell’underground inglese degli anni sessanta. Non fu il solo - nel Regno Unito - ad innestare un serio e radicale discorso politico in una musica di derivazione americana, che risentiva del sound di San Francisco, così come delle asprezze del rock più duro. Egli, però, seppe farlo in modo magistrale, senza alcuna smagliatura musicale o ideologica. I nomi d’obbligo da citare sono quelli di Capt. Beefheart, Frank Zappa, i Fugs, ma anche i Jefferson Airplane, Jimi Hendrix e i Grateful Dead. Per Broughton, musicista con una solida preparazione blues alle spalle, gli artisti citati furono molto più di un semplice riferimento. Il modo migliore per prendere confidenza con i Broughtons

è iniziare dall’ascolto dell’eccellente compilazione uscita nel 2001 della Emi/Harvest intitolata
"Out Demons Out", che contiene ben diciannove brani scelti fra i classici della loro discografia, oltre ad una versione inedita del brano
It's Not You. Il nucleo originale della band era costituito dai fratelli Robert detto 'Edgar' (24 ottobre 1947) e Steve Broughton (20 maggio 1950), rispettivamente alla voce/chitarra e alla batteria. Prima ancora però la dicitura della band fu Edgar Broughton Blues Band, che vedeva nei suoi ranghi un altro chitarrista, Victor Unitt.

Ai tre si aggiunse, quasi subito, il bassista Arthur Grant (14 maggio 1950) e, dal terzo album in poi, tornò il secondo chitarrista Victor Unitt (5 luglio 1946) proveniente dai blasonati Pretty Things. La band, sin dai suoi esordi, non fece affatto mistero delle proprie preferenze politiche e del proprio stile di vita hippie ed anarcoide. Si distinsero, infatti, per un’assidua partecipazione a tutti quanti i free festival del momento (quelli dove l’ingresso era gratuito, non tanto perché vi fosse un sponsor come oggi, ma perché c’era la volontà di fare musica senza compromessi

monetari). In questo modo, i Broughtons poterono contare sulla sincera partecipazione di un pubblico che vedeva in loro il modello di un gruppo fuori delle logiche di mercato, ben disposto nei confronti dei fan e lontano dalle rock star di Ready Steady Go (programma televisivo musicale della BBC). Il pubblico dei freak londinesi vide nella band, che suonava molto spesso senza alcun compenso, l’espressione sincera di un gruppo musicale che veniva dal popolo e

che sapeva rappresentare la gente. I fratelli Broughton erano nati nel Warwickshire e il loro arrivo nell’ex swinging London causò non pochi imbarazzi fra gli intellettuali radical chic della scena hippie.
Il successo insperato di questi strani hippie, molto provinciali, ma dalle idee chiare in fatto di politica, crebbe quando la band fu chiamata ad esibirsi come spalla nel celebre concerto gratuito di Hyde Park, che servì per lanciare l'avventura brevissima dei Blind Faith di Eric Clapton e Steve Windwood. Nell'agosto del 1969, quindi, la Harvest, etichetta creata dal gruppo EMI per seguire la musica progressiva, pubblicò
"Wasa Wasa", dopo che il compianto John Peel aveva già dato loro ampio spazio nel suo leggendario programma radiofonico Top Gear. Nel marzo del 1970 uscì il singolo
Out Demons Out,

che divenne rapidamente il brano più celebre delle loro esibizioni live, ma che curiosamente non fu pubblicato

in alcun LP del tempo, pur raggiungendo una posizione fra le più alte nelle classifiche inglesi. Si trattò, probabilmente del primo singolo di una band della Harvest ad entrare nelle charts. L'edizione in Cd della Repertoire di Wasa Wasa inserisce questo singolo fra le bonus track. Si tratta di un brano dall’incedere coinvolgente, registrato dal vivo con il pubblico che canta ad alta voce ogni qual volta Edgar cita le parole del titolo; la chiusura è affidata ad un lungo assolo di chitarra elettrica, che risente di una forte influenza hendrixiana.

Questa registrazione, tuttavia, ci offre soltanto una pallida idea di come potessero essere le apparizioni pubbliche di questa band, caratterizzate da espliciti atteggiamenti teatrali, sulla scorta dell’esperienza del Living Theatre e, più generalmente, dal situazionismo. Wasa Wasa fu, dunque, un esordio convincente. Nell’album, registrato presso gli studi Abbey Road, tutto il suono oscuro, cupo e minaccioso della band è reso appieno. Le chitarre distorte, con fuzz e wha wha, in puro stile hendrixiano e la batteria ossessiva e marziale si sposano alla perfezione con la voce profonda del leader. I brani dell’album sono tutti di alto livello a partire da
Evil, fino ad arrivare alla lugubre
Dawn Crept Away.
 Love In The Rain
Love In The Rain e l’indimenticabile
Why Can't Somebody Love Me, con il loro incedere da anthem, possiedono già la statura di autentici classici. L’atmosfera dei free concert non traspare troppo da questo lavoro, ma i testi risultano perfettamente in linea con la filosofia di vita della band. In particolare, la splendida
Death of an electric citizen sembra racchiudere tutta la critica di Broughton e soci contro l’establishment inglese. Il secondo lavoro dei fratelli Broughton fu
"Sing Brother Sing", pubblicato nel 1970 con un buon successo di classifica. L’album era dedicato al tema della 'cospirazione', trattata attraverso testi che legavano la sfera sociale e politica, a quella personale.Nel brano
Psychopath, ad esempio, l’Edgar Broughton Band affrontò il tema della masturbazione, un argomento scottante per il tempo, tanto da provocare alla band una messa al bando in Norvegia, smentendo, così, la leggendaria

convinzione che i paesi del nord siano più ‘aperti’ in materia di argomenti sessuali. La lunga suite intitolata
Moth è, invece, una sorta di collage sonoro realizzato mediante cut up, di grande effetto, ma poco innovativa. Nel frattempo uscì il singolo
Apache Drop Out che fondeva il classico degli Shadow
Apache con la corrosiva
Drop Out Boogie di Captain Beefheart. Il brano, una sorta di compendio delle ispirazioni della band, è stato inserito come bonus track nella riedizione della Repertoire del terzo album. L'anno seguente il gruppo, divenuto ormai un quartetto con l’aggiunta di Unitt, fece uscire l'album omonimo, con la celebre copertina dello studio Hipgnosis: una fotografia di quarti di bue squartati, in mezzo ai quali si intravede un uomo nudo appeso per i

piedi ad un gancio da macellaio. L’immagine non mancò di suscitare scalpore, così come i contenuti musicali.
"Edgar Broughton Band", infatti, era un’opera dal carattere molto sperimentale, registrata agli Abbey Road, con l'utilizzo di un’orchestra di oltre trenta elementi. Gli arrangiamenti e la direzione orchestrale venne affidata a David Bedford, mentre nel brano
Thinking of You, faceva la sua comparsa un giovanissimo Mike Oldfield al mandolino. Bedford proveniva dalla band di Kevin Ayers ed era amministrato dalla BlackHill Enterprise. Negli stessi anni realizzò numerose partiture orchestrali per molti artisti del tempo: Lol Coxhill, Roy Harper, Camel ed Anthony Moore (più recentemente ha lavorato anche per gli A-ha ed Ennio Morricone). Ciò nonostante, i suoi lavori più ricordati sono quelli con Mike Oldfield. Quest’ultimo, dopo un breve passato da turnista dell’underground inglese, anch’egli a fianco di Kevin Ayers, era divenuto uno dei pupilli di Richard Branson, boss della Virgin.

Il suo multimilionario album
"Tubular bells" fu realizzato presso i Manor Studios fra l’autunno del 1972 e la primavera del 1973, nei ritagli di tempo dei turni di registrazione di altri artisti. L’album quasi interamente registrato ed eseguito dallo stesso Oldfield vide la partecipazione di alcuni ospiti, quasi tutti provenienti dalla ricca scena underground inglese. Steve Broughton, ad esempio, fu incarico di registrare le parti di batteria, mentre a Jon Field membro dei leggendari Jade Warrior e dei July venne richiesto di inserire alcune parti di flauto. Fra gli altri ospiti illustri vi furono Lindsay Cooper degli Strawbs e Vivian Stanshall dei Bonzo Dog Doo Dah Band. Ad ogni modo, gli sperimentalismi troppo azzardati di Edgar Broughton Band non convinsero né il pubblico, né la critica del tempo. Ciò nonostante, il 1971 fu un anno magico per la band, che riuscì ad entrare nel gotha del rock grazie ad un’infuocata esibizione sul palco del Glastonboury Fayre Festival.

Si trattò di uno degli eventi più importanti dei primi anni settanta al quale presero parte gli Hawkwind, i Pink Faires, i Gong, Arthur Brown, i Traffic, i Quintessence, gli Help Yourself e David Bowie (che scrisse a tal proposito
Memories of a free festival).

Il palco era costruito a forma di piramide con degli ingenui, ma efficaci giochi di luce, mentre il pubblico, interamente costituito da freak inglesi, corroborati da droghe lisergiche e totalmente imbevuti di ideali hippie costituiva una folla enorme e variopinta. L’Edgar Broughton Band scelse tale occasione per presentare il nuovo chitarrista Victor Unitt e salì sul palco alla mezzanotte del 24 giugno eseguendo una travolgente versione di Out Demons Out della durata di venti minuti.Il brano è reperibile nel triplo album originale, stampato dalla
Revelation nel 1972. Quest’esibizione rappresentò la vera consacrazione per i Broughtons. Il pubblico

e le band inglesi, con il Festival di Glastonbury, si presero la loro rivincita sui loro coetanei americani e su Woodstock, che se paragonato a quello storico evento del 1971 aveva quasi il sapore di un festival rock da oratorio. In quegli anni l’Edgar Broughton Band trovò pieno inserimento nel tessuto musicale della scena londinese, soprattutto siglando un accordo con il management Blackhill Enterprises, lo stesso dei Pink Floyd.
"BBC Demons at the Beeb", pubblicato dalla Hux, è la fedele testimonianza delle BBC session della band. Si tratta di dodici tracce, quasi tutti dei classici, fra cui si segnala una selvaggia esecuzione live di
Out Demons Out
Demons Out realizzata per il programma Live in Concert di Radio One nel 1972. Queste esibizioni dal vivo, testimoniano le ottime capacità strumentali dei Broughtons. Non erano certamente dei virtuosi, ma possedevano un eccellente interplay in grado di generare un notevole apporto di dinamica ai loro brani. In questo modo riuscivano ad offrire delle esecuzioni live intense, ricche di energia e di potere comunicativo.
L’irriverente sperimentazione del terzo album non portò grandi benefici alla band, tanto che i due lavori successivi,
"In Side Out" e
"Oora", non riuscirono a scalare le classifiche di vendita, cosa che invece era riuscita piuttosto agevolmente ai primi

due album. Perso il contratto con la EMI/Harvest il gruppo cercò di riemergere nella seconda parte degli anni settanta, ma non riuscì a riacciuffare il treno del successo che pareva avere agganciato con il secondo e terzo album.
Oora, tuttavia, viene ritenuto da molti fan, uno fra gli album più interessanti della band. Quando uscì non registrò dei risultati di critica e pubblico sufficientemente positivi. Si trattava, infatti, di un’opera molto varia che spaziava fra brani dalla forte natura elettrica come
Hi-Jack Boogie o
Hurricane Man e canzoni acustiche come
Green Lights o la stessa
Rock‘n Roller.

Vi erano anche pezzi come
Roccococooler, un vero e proprio raga e altre tracce che non sembrano appartenere ad alcun genere. Ciò nonostante, vi sono ancora canzoni che hanno la statura di anthem come
Things On My Mind, giocata sui classici power chords, tipici delle composizioni di Broughton. In quasi tutti i brani affiorano effetti ambientali elettronici, scaturiti dai synth di Victor Peraino dei Kingdom Come, e l’atmosfera, a tratti, ha dei toni cupi e seriosi. Ciò nonostante, la penna di Edgar Broughton risulta sarcastica e corrosiva come sempre. L’album fu mixato presso gli attrezzatissimi Manor Studios di Richard Branson e la copertina fu realizzata da

Barney Bubbles, già grafico degli Hawkwind. Nonostante i notevoli sforzi della band per creare un album innovativo, i risultati scontentarono i fan degli esordi: più raffinata diveniva la musica dei Broughtons meno il pubblico pareva disposto ad ascoltarla.
"Bandages", album del 1975, fu il primo album che la band pubblicò dopo la sua dipartita dalla Harvest. Il disco segna la dipartita di Victor Unitt, sostituito da Terry Cottam. Si tratta di un album controverso, ma ricco

di fascino, che è stato recentemente rimasterizzato e ristampato dall’Eclectic disc, dopo ben quattordici anni dalla sua prima comparsa su CD. La scaletta è piuttosto eterogenea e spazia da brani acustici di grande raffinatezza, a brusche sterzate elettriche, vero asso nella manica della band, ma anche alcune tracce fortemente caratterizzate dall’impiego di sintetizzatori. La voce di Broughton è potente ed evocativa come sempre, mentre la struttura dei brani sembra voler recuperare il rock’n’roll degli esordi.Si tratta di un disco penalizzato dal fatto di non rientrare nella rosa degli album pubblicati dalla Harvest. In realtà, è un’opera godibile e ingiustamente sottovalutata. Lo

stesso vale per
"Live Hits Harder" album registrato durante il tour di addio della band nel 1976, anch’esso ristampato dalla Eclectic Disc, che contiene classici quali
Love in the Rain, Hotel Room, Evening Over Rooftops e
Side by Side. Chiunque abbia ascoltato questo live può rendersi conto di come dal vivo i Broughtons non avessero rivali, neppure a fine carriera. L’esecuzione, infatti, è come al solito intensa e selvaggia, gli arrangiamenti dei brani sono ridotti all’essenzialità, il sound è brutale e diretto. Il disco venne stampato solamente in

Svizzera, e con un certo ritardo. Nel frattempo la band, mutato il nome in Broughtons, era tornata in studio per registrare il discreto
"Parlez-Vous English?". L’ultimo capitolo della band originaria è
"Superchip", pubblicato con il nome di Edgar Broughton nel 1981 con scarso successo. La storia dell’Edgar Broughton Band è strettamente legata a

quella dell’hard rock e di quello che avrebbe potuto essere questo fenomeno musicale, se le apparenze disimpegnate dei lustrini glam non avessero affogato le istanze politiche che caratterizzavano la maggior parte delle band che facevano parte dell’embrionale scena hard rock inglese.
Simone Bardazzi
EdgarBroughtonBandMySpace
EdgarBroughtonBandLyrics Love in The Rain 1970
American Boy Soldier Live at Beat Club 1970
Why Can't Somebody Love Me? Da Live at the Beeb
Hotel Room (1972)
Love in The Rain 1970
American Boy Soldier Live at Beat Club 1970
Why Can't Somebody Love Me? Da Live at the Beeb
Hotel Room (1972)
discografia:
 Wasa Wasa (1969)
Sing Brother Sing (1970)
Edgar Broughton Band (1971)
Inside Out (1971)
Oora (1973)
Bandages (1975)
Parlez-Vous English? (1979)
Superchip (1982)
Chilly Morning Mama (Live) (1998)
Live Hits Harder (Live) (1979)
Demons at the Beeb (Live) (2000)
Keep Them Freaks a Rollin': Live at Abbey Road 1969 (Live) (2004)
Wasa Wasa (1969)
Sing Brother Sing (1970)
Edgar Broughton Band (1971)
Inside Out (1971)
Oora (1973)
Bandages (1975)
Parlez-Vous English? (1979)
Superchip (1982)
Chilly Morning Mama (Live) (1998)
Live Hits Harder (Live) (1979)
Demons at the Beeb (Live) (2000)
Keep Them Freaks a Rollin': Live at Abbey Road 1969 (Live) (2004)
 Si può addurre che, già all’iniettarsi il dondolio ipnotico Pan/Africano di Mushi, un suono sperimentale rimanga sempre un po’ perversamente familiare e partecipativo, tanto da inscatolarlo nella definizione concreta di lisergìa da condividere al massimo del delirio? Un timbro urgente e impulsivo può avere visioni di sangue fresco e d’antiche manipolazioni ciniche pazzesche? Sì, “Samurai Blues” è tutto questo, ed è anche un amuleto chiassoso per combattere le forze oscure della disfunzionalità del mondo rock, con i lineamenti sonori induriti e la dolcezza rumorosa di una piccola opera d’arte commista. Kawabata Makoto, il chitarrista “giallo” degli Acid Mothers Temple e l’Unno Mani Neumeier batterista della krautrock band degli anni sessanta Guru Guru Groove, da un
Si può addurre che, già all’iniettarsi il dondolio ipnotico Pan/Africano di Mushi, un suono sperimentale rimanga sempre un po’ perversamente familiare e partecipativo, tanto da inscatolarlo nella definizione concreta di lisergìa da condividere al massimo del delirio? Un timbro urgente e impulsivo può avere visioni di sangue fresco e d’antiche manipolazioni ciniche pazzesche? Sì, “Samurai Blues” è tutto questo, ed è anche un amuleto chiassoso per combattere le forze oscure della disfunzionalità del mondo rock, con i lineamenti sonori induriti e la dolcezza rumorosa di una piccola opera d’arte commista. Kawabata Makoto, il chitarrista “giallo” degli Acid Mothers Temple e l’Unno Mani Neumeier batterista della krautrock band degli anni sessanta Guru Guru Groove, da un  pò di tempo sodalizzano le rispettive esperienze musicali sotto il moniker Acid Guru Temple o Acid Guru Guru, oppure semplicemente con i loro nomi, e questo disco - una sorta di meraviglioso vagabondaggio free-jazz core tra derive, flussi e furore – ingoia libbre di trascendentale psichedelia e fondamentalismi noiseless che esaltano un ascolto indiavolato e mutante. Appunto cinque tracce per vessare magnificamente la propria psiche, ripulendola da quelle ballate sognanti, dalle riletture lenitive, da quella tradizionalità capace di riportarti il cuore verso lidi ed approdi sicuri; qui l’anfetamina è la sostanza più innocua che si possa trovare, una gioiosa macchina virtuosistica che si fa prima ad ascoltare che descrivere, forse un impatto/clangore
pò di tempo sodalizzano le rispettive esperienze musicali sotto il moniker Acid Guru Temple o Acid Guru Guru, oppure semplicemente con i loro nomi, e questo disco - una sorta di meraviglioso vagabondaggio free-jazz core tra derive, flussi e furore – ingoia libbre di trascendentale psichedelia e fondamentalismi noiseless che esaltano un ascolto indiavolato e mutante. Appunto cinque tracce per vessare magnificamente la propria psiche, ripulendola da quelle ballate sognanti, dalle riletture lenitive, da quella tradizionalità capace di riportarti il cuore verso lidi ed approdi sicuri; qui l’anfetamina è la sostanza più innocua che si possa trovare, una gioiosa macchina virtuosistica che si fa prima ad ascoltare che descrivere, forse un impatto/clangore  da club estasiato, ma senz’altro un hard-core jazzato ed evoluto in stile che tracima le insofferenze degli Hella e Minutemen e le sbatte sui lontani territori, ma molto lontani del blues del Mali. Makoto impasta rabbia, alienazione, diniego e ossessione in Another romance e ne restituisce cacofonia al quadrato, Neumeyer spiatta soffusamente nel mugugno mantrico di Spinning contrast, traccia purgatorio che sconta il peccato della bellezza ed insieme decidono di smontare tutto e darsi all’arte del “guazzabuglio”, destrutturando, storcendo quello che rimane di una batteria e cordame di chitarra elettrica. Libertà di comunicare noise, fuori dell’onanismo di tanti heroes dell’avanguardia, qui c’è noise-rock e avant-gard jazz che si uniscono sfogandosi per spolpare le trombe d’Eustachio, e che in fondo del fondo un tantino d’estenuazione la provocano, ma anche il “piacere del dolore” è una forma strana d’amore e allora adelante, che “dolore amorevole” sia.
da club estasiato, ma senz’altro un hard-core jazzato ed evoluto in stile che tracima le insofferenze degli Hella e Minutemen e le sbatte sui lontani territori, ma molto lontani del blues del Mali. Makoto impasta rabbia, alienazione, diniego e ossessione in Another romance e ne restituisce cacofonia al quadrato, Neumeyer spiatta soffusamente nel mugugno mantrico di Spinning contrast, traccia purgatorio che sconta il peccato della bellezza ed insieme decidono di smontare tutto e darsi all’arte del “guazzabuglio”, destrutturando, storcendo quello che rimane di una batteria e cordame di chitarra elettrica. Libertà di comunicare noise, fuori dell’onanismo di tanti heroes dell’avanguardia, qui c’è noise-rock e avant-gard jazz che si uniscono sfogandosi per spolpare le trombe d’Eustachio, e che in fondo del fondo un tantino d’estenuazione la provocano, ma anche il “piacere del dolore” è una forma strana d’amore e allora adelante, che “dolore amorevole” sia.